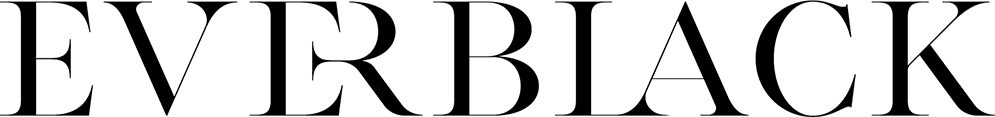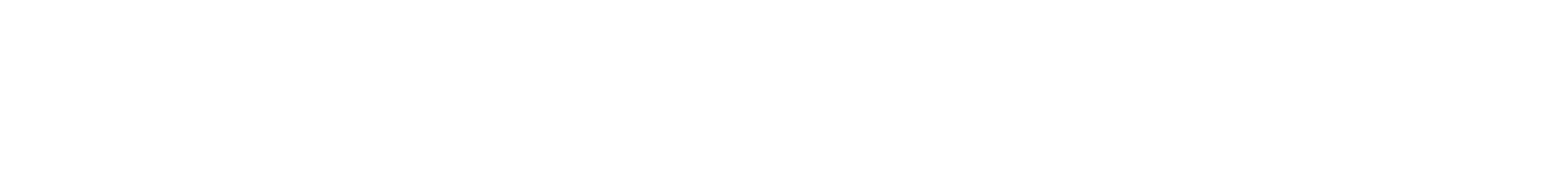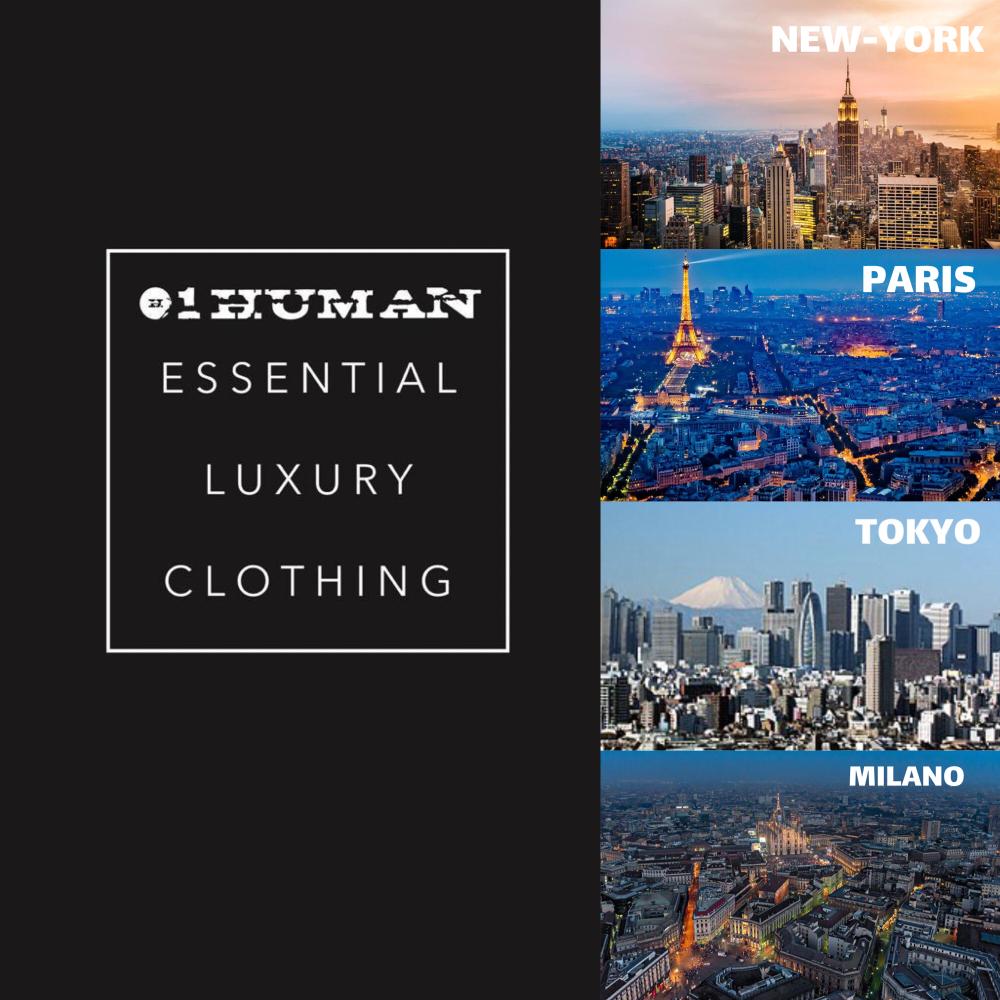Elvis – Recensione, lo spettacolo forsennato di Baz Luhrmann

Per chi si chiedesse se uno iato di dieci anni ne potesse addolcire lo stile, l’australiano Baz Luhrmann risponde all’inizio del suo ultimo film con un sonoro “no” . Un incipit frenetico, da mal di testa, che fuga qualsiasi dubbio: Elvis – di cui vi parliamo in questa recensione – è Luhrmann a 100 carati. Il ritorno in sala di un regista che, ce lo dichiara apertamente, non ha intenzione di scendere a compromessi.

Luhrmann mania
La parabola del Re del rock and roll Elvis Presley, a ben vedere, sembra essere da questo punto di vista il terreno perfetto per un esercizio baloccone come quello di Luhrmann, cineasta che della mancanza di autocontrollo ha fatto una parte integrante della sua visione filmica. Se c’è una cosa che il regista sembra aver assimilato, infatti, è il valore che la figura del Re ha avuto nella creazione di un immaginario comune e consolidato, di una storiografia culturale capace di resistere al passaggio del tempo. Non è semplicemente un Elvis pop, il suo: è Elvis, è il Pop.
Al di là del compendio kitsch, Elvis funziona più di tutti gli altri film dell’australiano come un repertorio di immagini stordenti, un caleidoscopio mediatico che si muove continuamente tra vecchio e nuovo (e la cover dei Maneskin in coda al film parla da sé), tra musica, cinema e televisione. Nel suo lavoro più massimalista ed espansivo (2 ore e 40 di durata) da molto tempo a questa parte, Luhrmann palesa un senso figurativo ovviamente straripante, ma sempre consapevole della statura vertiginosa del personaggio che racconta – e Austin Butler è sensazionale nel rendere Elvis umano e mitologico al tempo stesso.
Per questo motivo sembra ingiusto tacciare Luhrmann di superficialità, come hanno fatto alcuni. Perché il suo è un film volutamente “di superficie”, che lavora come quelli precedenti sulla contingenze culturali, sulla collisione visiva e musicale dove la visione umanistica del suo autore, caotica, iperattiva e sfarzosa, prende finalmente vita.
Un biopic più standard del previsto
Elvis, però, è pur sempre un biopic. E Luhrmann non è uno storyteller ribelle, ma il più esplosivo e rivoluzionario dei classicisti hollywoodiani. Lo è da sempre, oggi ancora di più. Non è quindi scardinando la storia che Luhrmann accende i riflettori sul protagonista, ma lavorando sulla struttura ben collaudata del cinema classico, sul racconto dell’ascesa e della discesa del divo – come vuole il paradigma dello storytelling tradizionale. Qui entra in funzione il meccanismo narrativo del film, che è raccontato dal punto di vista del Colonello Parker (Tom Hanks). Manager, imprenditore, domatore del Presley show, il Colonnello è l’impresario responsabile della nascita del mito di Elvis. Un imbonitore da circo, si dice a un certo punto, capace di fare del giovane un prodotto confezionato a dovere. È l’altra faccia della favola: il soggetto sognatore che diventa oggetto di desiderio.

La visione materialista dell’imprenditore fornisce l’architettura di tutta la storia. Elvis non è solo il protagonista da cui scaturisce la luminosità accecante del film, ma è anche il centro dell’attrazione di tutte le parti coinvolte: di Luhrmann, del pubblico adorante, del suo manager bramoso di denaro. La storia di una vittima dello show business che nella sua leggendaria magnitudine finisce per essere incastrato.
Quella che dovrebbe essere la colonna portante del racconto risulta tuttavia la linea meno sviluppata e interessante. Il problema sta proprio in Parker, la cui caratterizzazione non riesce a supportare il ruolo fondamentale che Luhrmann gli affida. Figura evanescente e cruciale al tempo stesso, il Colonnello rimane nascosto dietro un’avarizia enigmatica di cui non si sa mai nulla, una sete di denaro e potere che, privata di motivazioni, finisce per sembrare posticcia, vuota, caricaturale.
Forse era proprio quella l’idea del regista: fare di Parker una macchietta, uno specchio su cui riflettere il vuoto del consumismo che nasceva in quegli anni – come se il Colonnello fosse in qualche modo il simbolo di un’intera società, di un modo di vedere gli uomini come oggetti da sfruttare. Ma il suo ruolo nella storia è troppo specifico perché Luhrmann riesca ad astrarre il personaggio dalla realtà narrativa del film. Parker rappresenta il vero motore della vicenda: è lui che lancia Elvis verso lo stardom e lo manipola per profitto personale, ed è sempre lui l’artefice della disfatta del Re. Un personaggio vero e determinante, quindi, che non riesce però a concretizzarsi nella dimensione filmica. Resta a galla, attraversa le scene, appare e scompare nel suo stato allucinatorio e nella performance di un Hanks spaesato e poco incisivo.
Mitologia culturale

Nel tentativo di fare del suo Elvis non solo uno spettacolo stratosferico, ma anche un semplice racconto, il regista australiano si è dimenticato di creare un antagonista veramente memorabile. Ma forse per Luhrmann quello di Hanks è un personaggio secondario, che nella sua piatta grettezza merita di essere relegato allo sfondo. La cornice allora conta poco, diventa un elemento superfluo.Conta, invece, la devozione, la passione per la musica, il coinvolgimento sensoriale che anima le sequenze in cui Butler-Presley la fa da padrone. Sono momenti genuinamente e cinematograficamente sensazionali, in cui l’incandescenza di Luhrmann appare per una volta giustificata, perché mossa da una comprensione viscerale per l’anima tragica del suo eroe. Sprazzi di allucinante, vivissima mitologia pop che vale la pena di vivere (e ascoltare) sul grande schermo.
[rwp-review id=”0″]